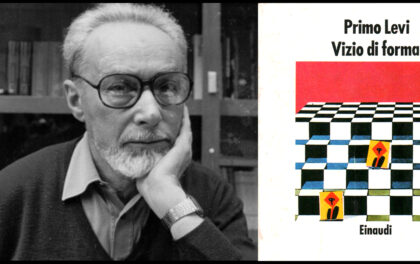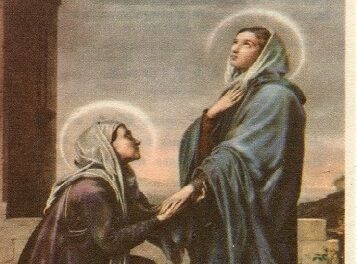Andreotti visto dal Manifesto
 Tempo di lettura: 4 minuti
Tempo di lettura: 4 minutiDopo la morte di Giulio Andreotti si è assistito a un’opera di damnatio memoriae contro la sua persona. Non era un santo, ma non era neanche Balzebù, come ben sanno coloro che lo criticano. Solo un povero cristiano prestato alla politica che ha tentato di fare, nonostante i tanti condizionamenti dovuti a Yalta e al potere di questo mondo, il proprio dovere. Con alterni successi e tante benemerenze. In Spiragli abbiamo riportato l’eterna gratitudine che gli ha tributato il Presidente israeliano, e nobel per la Pace, Shimon Peres, come anche gli elogi pubblici del Presidente russo, memore del ruolo di mediazione svolto da Andreotti tra il suo Paese e l’Occidente prima e dopo Yalta, che ha attutito attriti e creato spazi di dialogo. Ci si sarebbe aspettato, se non un omaggio pubblico allo statista, un civile esercizio di umana pietas. Così non è stato.
Anche per questo riportiamo un articolo pubblicato il 7 maggio dal Manifesto. a firma di Andrea Fabozzi, che in qualche modo rende giustizia alla figura dello statista democristiano. Presenta lacune, lo scritto, nondimeno tante circostanze che descrive hanno fondamento e intelligenza.
C’è, anzi c’era, un uomo politico che in questi vent’anni di «seconda Repubblica» è stato contro la partecipazione dell’Italia alle guerre in Kosovo e Afghanistan, contro la guerra in Iraq al punto da chiedere al governo di rispondere in parlamento per le bugie sulle armi di distruzione di massa di Saddam (che non c’erano), naturalmente contro l’intervento in Libia e tradizionalmente incline alle ragioni dei palestinesi al punto di dichiarare un giorno che che se fosse nato profugo in Libano «sarei stato un terrorista»; un politico che dopo l’89 ha tifato per lo scioglimento della Nato e comunque della riduzione della presenza militare in Italia e dopo il 2001 si è messo di traverso alle filippiche anti Islam di Oriana Fallaci; un politico che nel dibattito sulle riforme ha difeso la Costituzione del ’48 (che aveva contribuito a scrivere) sostenendo la necessità di attuarla nei suoi principi sociali prima di cambiarla e ha criticato il bipolarismo rissoso, schierandosi per una legge elettorale proporzionale; un cattolico amico e confidente dei papi che quando i curiali spingevano per introdurre le radici cristiane nella costituzione europea ha suggerito di soprassedere perché «l’importante non è dirsi cristiani ma esserlo» e poi quando il governo di centrodestra ha tentato di intromettersi per decreto nelle scelte di Eluana e Peppino Englaro ha ricordato che la politica non deve immischiarsi nei drammi privati, ma rispettarli. Era un uomo politico che di «seconda Repubblica» non voleva sentir parlare perché la Costituzione formale «è ancora quella», ma al quale il campione assoluto della seconda Repubblica e della Costituzione materiale, Silvio Berlusconi, si è spesso voluto paragonare, in nome della comune sorte giudiziaria. Fino a ieri, con un’ultima scomposta dichiarazione: «Conosco bene il metodo che hanno usato contro di lui».
Giulio Andreotti non aveva le scarpe col rialzo. Sembrava basso per via della gobba, invece a stargli accanto lo si scopriva alto. E a rileggere i suoi interventi politici degli ultimi vent’anni lo si trova lontanissimo dal berlusconismo. Che pure tanti omaggi gli ha tributato quando, caso unico nella storia d’Italia, i suoi novant’anni sono stati festeggiati con una seduta del senato. I cinque decenni nei quali ha dato forma alla destra democristiana pesano naturalmente di più degli ultimi due nei quali si è tenuto un po’ in disparte, avendo chiuso con il suo settimo governo (1992) l’era pre-Tangentopoli. Messo all’angolo dalle accuse e dai processi più che dalle condanne e dalle prescrizioni, ha aderito al partito popolare nato dalle ceneri della Dc ma senza alcun entusiasmo. La sua corrente era piccola e più capace di manovre che di influenze, così a eccezione del soft power dell’eminenza azzurrina Gianni Letta, l’impatto degli andreottiani sull’organizzazione berlusconiana – che pure ha ereditato buona parte dei voti democristiani – è stato modesto. La breve carriera di qualche seconda fila come il laziale Publio Fiori e il lombardo Luigi Baruffi, molto meglio di loro si è riciclata con il Cavaliere l’ala affarista dell’andreottismo. Da Ciarrapico a Caltagirone, per il cui genero Pier Ferdinando Casini Andreotti ha votato l’ultima volta, ma solo – raccontò – per lo scudo crociato nel simbolo Udc, «un fatto sentimentale».
Eppure fu Berlusconi a riportare il divo Giulio per qualche giorno al centro delle cronache politiche, quando nel 2006 provò a scalzare il candidato del centrosinistra alla presidenza del senato – Franco Marini – puntando sull’ottantasettenne Andreotti. Il piano fallì e Andreotti sembrò prenderla sportivamente, confermando da senatore a vita la fiducia al governo Prodi, che pure traballava e contava ogni voto. Continuò così un paio d’anni, con i berlusconiani che cominciavano ad accusare zio Giulio di ingratitudine. Poi Andreotti mancò un voto, uno solo, il giorno del gennaio 2008 che Prodi andò sotto, fu sfiduciato e si dimise.
La lungimiranza in politica è una gran dote e allora bisogna citare quello che il senatore suggerì a centrodestra e centrosinistra sette anni fa: «Il candidato più adatto a guidare una grande coalizione se nessuno dovesse prevalere nettamente è Letta». Disse solo il cognome.