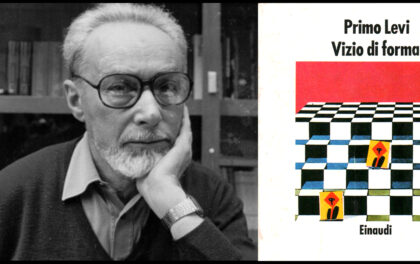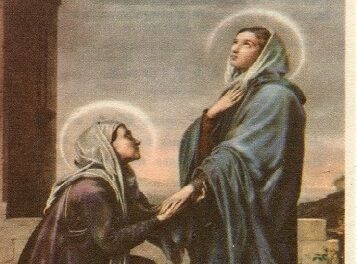In memoria di Giulio Andreotti
 Tempo di lettura: 9 minuti
Tempo di lettura: 9 minuti«Io sono solo un popolano romano», diceva di sé, con quella sobrietà che ha sempre contraddistinto le sue interviste. Eppure Giulio Andreotti era certamente l’uomo politico italiano più noto al mondo. Ma questo era il suo modo di far intendere che il potere che aveva esercitato gli era arrivato quasi per caso. Da quando, giovane studente di animo antifascista, venne indicato a De Gasperi, perché lo prendesse sotto la sua ala protettrice dall’allora monsignor Giovanni Battista Montini, che al tempo operava presso la Segreteria di Stato vaticana (ne accenna, nel suo modo riservato, Andreotti nei diari pubblicati di recente). E quello con Montini è stato il rapporto più importante della sua vita, fino al ̓78, anno della morte di Paolo VI. Il terribile ’78, come lo definiva spesso Andreotti, l’anno dei tre Papi. Durante il quale i terroristi avevano rapito e ucciso Aldo Moro, colui con il quale il senatore aveva condiviso l’esperimento politico più affascinante della storia politica italiana: il compromesso storico.
Già, la morte di Moro: una vicenda di cui parlava poco, perché quella tragedia nazionale per lui fu strazio personale per l’amico cresciuto insieme a lui nella Fuci. Aveva tentato di tutto per salvarlo, nelle ristrettezze in cui era necessario muoversi in quel terribile momento storico, schiacciati come si era dalla necessità di non cedere ai terroristi, come dall’ostilità di alcuni ambienti anglosassoni e sovietici verso quell’impensabile compromesso che minava il loro potere internazionale (in Occidente si aveva paura di perdere un alleato fondamentale per il Mediterraneo e l’Europa, in Unione sovietica che l’Italia diventasse polo d’attrazione alternativo per il comunismo internazionale); e da un’ostilità interna non solo extraparlamentare, dal momento che la loggia Propaganda 2 condivideva con quegli ambiti la contrarietà per le convergenze parallele Dc-Pci. Ma l’avversione alla Chiesa e alla Dc spirava anche da altri ambiti: fu nei giorni terribili del sequestro Moro che il Parlamento italiano approvò la legge sull’aborto, nonostante la Dc avesse chiesto di rimandare il dibattito; cosa che non avvenne e che costrinse Andreotti, presidente del Consiglio, a firmare la relativa norma: non firmarla avrebbe comportato la caduta del governo e, con Moro ancora in mano ai terroristi, lasciare il Paese senza guida avrebbe causato danni irreversibili.
Eppure, nonostante tutto, si era quasi riusciti a liberare il prigioniero. Lo accenna lo stesso Moro nel suo memoriale: «Questa essendo la situazione, io desidero dare atto che alla generosità delle Brigate Rosse devo, per grazia, la salvezza della vita e la restituzione della libertà. Di ciò sono profondamente grato. Per quanto riguarda il resto, dopo quello che è accaduto e le riflessioni che ho riassunto più sopra, non mi resta che constatare la mia completa incompatibilità con il partito della D.C. Rinuncio a tutte le cariche, esclusa qualsiasi candidatura futura, mi dimetto dalla D.C., chiedo al Presidente della Camera di trasferirmi dal gruppo della D.C. al gruppo misto». Lo ripeteva spesso questo passaggio del memoriale, Andreotti, annettendogli importanza fondamentale.
La liberazione di Moro fu narrata anche dal giornalista Carmine Pecorelli, che ne scrisse nel suo giornale, spiegando che la trattativa era andata in porto e lo statista era stato liberato, ma che poi qualcuno aveva giocato al rialzo, assassinandolo egualmente. Il “macellaio”, scriveva Pecorelli, si chiamava Maurizio, nome di battaglia dell’uomo chiave del terrorismo italiano, Mario Moretti; il quale, più tardi (fu arrestato nell’81), confessò il delitto, anche se lo descrisse in maniera diversa. Quando ne scrisse Pecorelli non era ancora stato accertato.
Un libro pubblicato di recente, La zona franca di Alessandro Forlani, documenta nei dettagli come in effetti la Dc fosse in attesa della liberazione di Moro, dopo trattative segrete condotte sottotraccia, e che, invece, la notizia del suo omicidio giunse ai suoi compagni di partito come una staffilata.
D’altronde resta ancora inspiegata la perizia della polizia scientifica sul cadavere dello statista, riportata anche su un libro di Sergio Flamigni, secondo la quale i colpi erano stati esplosi dall’interno della Renault 4, che aveva i sedili posteriori ribaltabili, e non dall’esterno. Scenario che ben si attaglia a un omicidio avvenuto proditoriamente, presumibilmente mentre l’auto era in movimento per liberare il prigioniero; come si narra nel romanzo La borsa del Presidente, scritto da uno dei fondatori delle Brigate Rosse, Alberto Franceschini.
Ma se di punti oscuri la vicenda Moro ne presenta ancora tanti, uno è alquanto noto e allo stesso tempo poco ricordato: solo nella lettera indirizzata ad Andreotti, Moro, dal carcere in cui era rinchiuso, raccomanda la sua famiglia: «Che Iddio ti illumini e ti benedica e ti faccia tramite dell’unica cosa che conti per me, non la carriera cioè, ma la famiglia».
La morte di Moro segna uno spartiacque fondamentale nella vita di Andreotti. Al punto tale da decidere di fare un passo indietro nella politica. Ritornò più tardi, con una Dc ormai diversa dopo la morte dell’amico fucino; una Dc che parlava un po’ inglese, per parafrasare un illuminante passaggio del memoriale dello statista assassinato. Dopo aver ricoperto cariche da ministro, alla fine degli anni ’90 Andreotti divenne di nuovo, per l’ultima volta, Presidente del Consiglio. Un’esperienza che, nel ’92, lo aveva proiettato verso il Quirinale. Ma, come ha ricordato l’onorevole Claudio Martelli, la strage di Capaci in cui perì il magistrato Giovanni Falcone cambiò improvvisamente tutto.
Quel Falcone che raccolse la testimonianza di un pentito, Giuseppe Pellegriti, che per primo accusò l’onorevole Salvo Lima di collusione con la mafia (un tassello importante, perché proprio dall’accusa contro Lima si sarebbe giunti a incriminare Andreotti). Falcone non si fece ingannare e fece condannare il pentito per calunnia.
Eppure, dopo l’assassinio del magistrato siciliano, avvenuto nell’ambito di una trattativa tra lo Stato e la mafia (come da inchieste giudiziarie in corso), l’accusa tornò impetuosa e straripante. Una tempesta nella quale Andreotti riuscì a conservare la sua lucidità. Ricordo bene quegli anni, perché con amici aiutai la difesa a leggere la mole di carte che si andava accumulando sotto la dettatura di un centinaio di “pentiti” di Cosa Loro. Che poi tanto “pentiti” non erano, dal momento che uno di questi, quel Balduccio Di Maggio che aveva parlato del bacio tra Andreotti e Riina, accusa fondante dell’inchiesta, fu arrestato dopo aver ucciso alcune persone durante il periodo della “protezione”.
Poi all’accusa per mafia si aggiunse anche quella di omicidio, nella persona del giornalista Carmine Pecorelli. Altre carte da leggere, altro fronte dal quale difendersi.
I processi si risolsero felicemente, nonostante alcuni rumorosi detrattori continuino a dire che il Tribunale di Palermo avrebbe riconosciuto ad Andreotti una contiguità con la mafia fino agli anni ’80. Pur tenendo per buona questa interpretazione della sentenza, ci sarebbe da spiegare perché all’improvviso, agli inizi degli anni ’90, centinaia di mafiosi si “pentirono” iniziando a raccontare cose. Fenomeno mai accaduto prima né più ripetuto nella storia della mafia. Perché tanti di questi, tra cui un sedicente affiliato a un’organizzazione atlantica della Nato, hanno raccontato nei dettagli incontri tra boss e Andreotti negli anni Novanta, consegnando ai magistrati descrizioni delle persone presenti a queste riunioni segrete, accurate descrizioni dei luoghi, circostanze specifiche che i giudici terzi hanno riscontrato come non veritiere perché Andreotti ha documentato in maniera inoppugnabile i suoi spostamenti.
Perché, inoltre, nessun pentito di quella felice stagione ha portato al sequestro di un qualche carico di droga o all’individuazione di una raffineria clandestina della stessa, eppure è noto che la mafia non commercia solo in caramelle… Domande banali che gettano ombre su quanto è avvenuto veramente in quegli anni. Che troveranno risposta, forse, nei tribunali della storia.
In ogni caso, era talmente imponente l’accumulo di carte accusatorie che sembrava impossibile leggere tutto e difendersi. E invece… Anni durissimi, per il senatore. Ma anche qui, con quel senso delle istituzioni e della misura che lo ha sempre contraddistinto, non ha fatto tragedie: a un suo ex collega di partito, andreottiano (celebre l’intervista in cui Andreotti dichiarò di non essere mai stato andreottiano), che accennava a quella vicenda giudiziaria come a un Calvario, rispose indirettamente a mezzo stampa che il paragone era irriverente: il Calvario è un monte santo, spiegò, io sono un povero peccatore… Si difese senza cercare scorciatoie extra-giudiziarie, stringendo la mano al suo grande accusatore, Giancarlo Caselli, approdato in terra siciliana il giorno della cattura di Totò Riina. Come anche a Rosita Pecorelli, sorella del giornalista ucciso.
Tante altre cose si potrebbero scrivere di quelle vicissitudini giudiziarie, ma non è questa la sede.
Di Andreotti piace ricordare quel che gli era più caro, la fede in Gesù. Che non ha mai ostentato, al contrario di altri cattolici “impegnati” in politica. Il topos vuole che frequentasse sagrestie e ambienti curiali. Una verità parziale, come testimoniano gli innumerevoli attestati di affetto e di stima pervenuti a 30giorni negli anni da tanti monasteri e missionari del mondo intero. Del resto capitava, girando per Paesi sperduti per conto del giornale, di imbattersi in sacerdoti, suore e missionari che ringraziavano per qualche dono del direttore, per qualche attenzione ricevuta e altro.
Non diceva mai nulla della beneficienza che faceva, secondo la raccomandazione evangelica, ma era risaputo, tra l’altro, che tutto lo stipendio che percepiva dal nostro giornale prendeva quella strada. Così come taceva del suo rapporto privilegiato con Madre Teresa di Calcutta e con tanti altri uomini e donne di quella “classe media della santità” che abitano il mondo. Non ne ha mai voluto parlare lui, non ne parleremo noi.
Dello statista che ebbi modo di conoscere ricordo quelle riunioni di redazione nelle quali raccontava il mondo, dispiegava scenari internazionali e prospettive future. In una di queste, era appena iniziata la guerra in Iraq voluta da George W. Bush, chiese di valorizzare i diari dell’ambasciatore italiano in Vietnam, nel quale il diplomatico spiegava come gli americani avessero intrapreso l’operazione militare indocinese pensando a un’avventura di breve durata, mentre invece sarebbe stata lunga e incerta. È storia che la guerra irachena, annunciata come un blitzkrieg, durò molto più a lungo di quanto previsto dagli improvvisati strateghi di Washington… Ma è solo un esempio, tra tanti, delle sue felici intuizioni; altri se ne potrebbero fare, anche su quell’11 settembre del 2001 sul quale si chiedeva cosa avesse accertato l’inchiesta Usa che doveva appurare gli impressionanti giochi speculativi che si erano dipanati poco prima dell’attentato che avrebbe sconvolto il mondo e fatto dilagare il terrorismo internazionale.
Nel suo parlare, facile alla battuta, accennava spesso ai suoi amici arabi, come anche ai suoi amici ebrei (d’estate si ritrovava con alcuni di loro in Francia) e ai vari rapporti sparsi nel resto del mondo: russi, americani, cinesi, iraniani. Un tesoro di conoscenze accumulato nel dialogo con tutti, senza discriminazioni previe. Grazie a questi rapporti era diventato un tramite: tra ebrei e arabi, tra russi e americani, tra il mondo laico e la Chiesa. Da qui la sua grandezza, che prescindeva dallo scenario italiano, al quale pure era ancorato. E che spendeva per attutire ostilità e cercare vie di convergenza. In particolare in Medio Oriente, per il quale tentò con pazienza e perseveranza di facilitare iniziative di pace tra israeliani e palestinesi. A questo proposito ricordo una sua intervista dopo il rinvio a giudizio di Perugia per il processo Pecorelli. All’intervistatore che gli chiedeva se provasse tristezza per la nuova tegola giudiziaria, rispondeva di essere triste piuttosto per l’assassinio del premier israeliano Rabin (che aveva intrapreso la via della pace dei coraggiosi insieme ad Arafat), avvenuto lo stesso giorno.
Al suo arrivo a 30giorni intervistò Arafat e Gheddafi; a proposito di quest’ultimo, del quale riconosceva i limiti, ripeteva spesso di come fosse un argine al dilagare del fondamentalismo islamico e che la Libia era stato il primo Stato a spiccare un mandato di cattura internazionale contro Osama Bin Laden, nell’indifferenza generale. Ma sicuramente l’intervista che ebbe più cara fu quella a don Luigi Giussani, che pubblicò su 30giorni in anni difficili per la Chiesa del Signore.
Ricordo che quando don Giacomo Tantardini mi telefonava in redazione, andavo a rispondere usando il telefono della sua stanza. E gli occhi immancabilmente cadevano sulla foto che aveva sempre sulla sua scrivania, ritraente Andreotti e Giussani che si guardavano sorridenti come bambini. Un’immagine che raccontava più di tante parole il rapporto tra i due e che, insieme, era sguardo comune sulla Chiesa.
La Chiesa, in fondo, era la cosa che più interessava il «popolano romano» Giulio Andreotti. Raccontava spesso della Roma papalina nella quale era cresciuto e con la quale intratteneva fecondi rapporti. Quand’era direttore di Concretezza (termine che sintetizzava la sua visione della politica), durante il Conclave del ’58, indovinò quale sarebbe stato il successore di Pio XII, facendo la copertina sul patriarca di Venezia Angelo Roncalli.
Da un giornale all’altro: da direttore di 30giorni, dopo la morte di Giovanni Paolo II, fece pubblicare un editoriale a firma del cardinal Joseph Ratzinger (unico editoriale a firma di un cardinale). Felici intuizioni, unite a una sensibilità unica nell’individuare le istanze e le prospettive della Chiesa.
 Durante la direzione di 30giorni, mensile al quale dedicò particolare attenzione, ebbe modo di approfondire la sua conoscenza con don Giacomo Tantardini, che gli aveva affidato la rivista e con il quale nacque una sinergia che portò il mensile a diventare una delle più autorevoli voci del mondo cattolico. Si conoscevano già i due, ma da allora nacque un’amicizia commovente. Tanto che la scomparsa dell’amico sacerdote, avvenuta poco più di un anno fa, lo provò duramente.
Durante la direzione di 30giorni, mensile al quale dedicò particolare attenzione, ebbe modo di approfondire la sua conoscenza con don Giacomo Tantardini, che gli aveva affidato la rivista e con il quale nacque una sinergia che portò il mensile a diventare una delle più autorevoli voci del mondo cattolico. Si conoscevano già i due, ma da allora nacque un’amicizia commovente. Tanto che la scomparsa dell’amico sacerdote, avvenuta poco più di un anno fa, lo provò duramente.
In particolare, su don Giacomo ebbe modo di scrivere in un editoriale dedicato a don Giussani, pubblicato sul numero 10 del 2011 di 30giorni. E per parlarne descrisse la messa a San Lorenzo fuori le Mura celebrata dal suo amico sacerdote. Quell’editoriale si concludeva in questo modo: «Ma, tornando a don Giussani, l’altra cosa che mi ha permesso di capirlo meglio è stato partecipare molte volte in questi anni alla messa nella Basilica di San Lorenzo fuori le Mura che celebra don Giacomo Tantardini, un sacerdote che ha sempre manifestato nei confronti di don Giussani ammirazione e devozione; presentandolo sempre come il punto di riferimento al quale guardare. Mi è capitato molte volte, da quando sono diventato direttore di 30Giorni, di partecipare a queste messe del sabato sera, ai battesimi, alle cresime, e ogni volta ho visto qualcosa di unico: studenti e lavoratori, giovani sposi con i bambini per mano che vanno insieme a ricevere la comunione, una cosa veramente paradisiaca. Mi sono chiesto, anche grazie a una fortunata copertina di 30Giorni del 2008 dedicata a Lourdes, se non fosse poi questo il futuro del cristianesimo, il modello del laicato per i prossimi anni».
A rileggere adesso queste righe viene da sorridere: Papa Benedetto XVI si è dimesso nel giorno della festa della Madonna di Lourdes e a lui è succeduto il cardinale Jorge Mario Bergoglio, cardinale che don Giacomo aveva indicato come speranza per la Chiesa. Le vie della Provvidenza sono imperscrutabili e, anche per questo, abitate da grazia imprevista quanto felice.