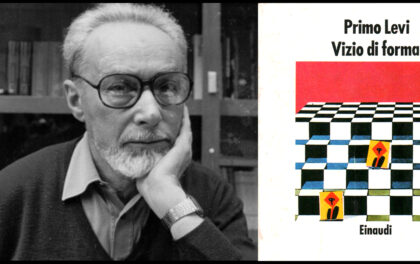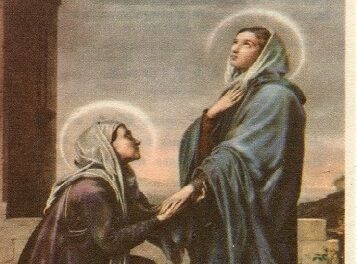«Io sono un semplice battezzato». Marcello Candia, il cammello passato per la cruna dell'ago
 Tempo di lettura: 7 minuti
Tempo di lettura: 7 minutiIl 22 luglio il Papa si recherà in Brasile. Nell’occasione piace ricordare un figlio della Chiesa ambrosiana che tanto ha dato a quel Paese lontano: Marcello Candia, di cui quest’anno ricorrono i trent’anni dalla morte. Nel Paese carioca attorno a Candia fiorirono diverse opere di carità, in particolare il lebbrosario di Marituba che gli fu particolarmente caro.
Nell’omelia tenuta in occasione della festività di san Tommaso, papa Francesco, nel ricordare l’incredulità dell’apostolo, ebbe a dire: «dobbiamo baciare le piaghe di Gesù, e questo letteralmente. Pensiamo, cosa è successo a San Francesco, quando ha abbracciato il lebbroso. Lo stesso che a Tommaso: la sua vita è cambiata!». È quanto successe a Candia, in Italia, come nel “suo” Brasile. Candia, che era uomo ricco e stimato, e che ha testimoniato come una Chiesa povera per i poveri – così nel cuore di Francesco – si realizza attraverso le modalità più impreviste, secondo l’infinita fantasia del Signore.
«Quando cammino per strada ripeto sempre: “Signore dammi la fede”», confidò una volta ad uno dei suoi amici il servo di Dio Marcello Candia. E di strada, quell’industriale con il Vangelo sempre custodito nella tasca interna del doppiopetto blu da commenda, ne ha fatta davvero tanta: un viaggio splendido e densissimo, iniziato tra gli ultimi della sua Milano e terminato tra i malati e i lebbrosi dell’Amazzonia equatoriale brasiliana. Sempre con il rosario tra le dita e le preghiere imparate da bambino a fior di labbra. «Io sono un semplice battezzato», ripeteva continuamente a tutti, specialmente a coloro che chiedevano come mai non facesse parte di alcun movimento o congregazione religiosa: «Io sono un laico, ma anche un consacrato – rispondeva sorridendo – Il battesimo mi ha trasformato, la cresima mi ha impegnato a diventare un testimone di Cristo, non ho bisogno d’altro».
Sin dai primi anni ’50 gli amici avevano iniziato a chiamarlo scherzosamente «il dottor Macapá», per via di quello “strano pallino” di voler partire missionario fra gli ultimi dell’Amazzonia brasiliana. Già, perché Marcello, dopo l’incontro con monsignor Aristide Pirovano, non aveva più smesso di parlare di quella cittadina sperduta nel Nord Est brasiliano di cui il brianzolo missionario del Pime, amico di Giovanni Battista Montini, gli aveva illustrato le miserie; e dove, era inteso, prima o poi si sarebbe recato personalmente in missione, per restarvi.
 Candia – classe 1916, tre lauree e una splendida carriera imprenditoriale all’attivo – proveniva da una delle famiglie più importanti della città, proprietaria di una delle prime industrie chimiche d’Europa. Tuttavia lo sfondo della vita di Marcello non fu soltanto quello degli scintillii della Milano bene di cui pure faceva parte; ben più variegato, esso comprendeva anche i colori sofferti di un’altra Milano, quella che aveva conosciuto sin da piccolo accompagnando la madre Luigia a visitare i poveri della Congregazione san Vincenzo; e poi da adolescente, aiutando gli amici cappuccini a sfamare i senzatetto; e, ancora, durante la Seconda Guerra Mondiale, pagando di tasca propria a prigionieri politici ed ebrei i documenti falsi per poter fuggire e aver salva la vita; e, di nuovo, nel Dopoguerra, organizzando impressionanti reti di aiuto, mentre i treni provenienti da ogni dove riversavano nella stazione della città reduci di guerra sprovvisti di tutto e ragazze madri che avevano conosciuto sulla propria carne la violenza della guerra. Marcello c’era sempre: «In tutto ciò che il Signore mi fa incontrare io mi ci butto dentro», era solito dire. E in effetti, nel capoluogo lombardo vi furono anni, scriveva il giornalista Giorgio Torelli, «durante i quali ognuno seppe – poveri, frati, preti, suore, vescovi, soprattutto il cardinale Montini – cosa fosse d’inesausto la festosa carità del dottor Marcello».
Candia – classe 1916, tre lauree e una splendida carriera imprenditoriale all’attivo – proveniva da una delle famiglie più importanti della città, proprietaria di una delle prime industrie chimiche d’Europa. Tuttavia lo sfondo della vita di Marcello non fu soltanto quello degli scintillii della Milano bene di cui pure faceva parte; ben più variegato, esso comprendeva anche i colori sofferti di un’altra Milano, quella che aveva conosciuto sin da piccolo accompagnando la madre Luigia a visitare i poveri della Congregazione san Vincenzo; e poi da adolescente, aiutando gli amici cappuccini a sfamare i senzatetto; e, ancora, durante la Seconda Guerra Mondiale, pagando di tasca propria a prigionieri politici ed ebrei i documenti falsi per poter fuggire e aver salva la vita; e, di nuovo, nel Dopoguerra, organizzando impressionanti reti di aiuto, mentre i treni provenienti da ogni dove riversavano nella stazione della città reduci di guerra sprovvisti di tutto e ragazze madri che avevano conosciuto sulla propria carne la violenza della guerra. Marcello c’era sempre: «In tutto ciò che il Signore mi fa incontrare io mi ci butto dentro», era solito dire. E in effetti, nel capoluogo lombardo vi furono anni, scriveva il giornalista Giorgio Torelli, «durante i quali ognuno seppe – poveri, frati, preti, suore, vescovi, soprattutto il cardinale Montini – cosa fosse d’inesausto la festosa carità del dottor Marcello».
Quindici anni e numerose prove (una su tutte, l’esplosione dello stabilimento milanese che gli costerà sofferenze e una serie interminabile di processi, prima di venir completamente assolto) non scalfirono il desiderio di quella partenza per il Brasile, avvenuta finalmente nel 1965. Marcello aveva quasi cinquant’anni, non parlava una parola di portoghese, le sue condizioni di salute non erano buone e soprattutto stava lasciando una vita agiatissima per finire i suoi giorni in uno dei luoghi più ostici del mondo, per clima e miseria. Tuttavia, quando comunicò ad amici e familiari la decisione di vendere la propria azienda e utilizzare tutto il suo enorme patrimonio per costruire un ospedale per i poveri a Macapá, sebbene in molti lo credettero folle, probabilmente nessuno si stupì davvero. Tantomeno Montini, vero ispiratore di quel progetto, che ormai salito sul soglio di Pietro incoraggiò e benedisse in modo del tutto speciale quell’industriale che stava per mettere a servizio di Dio e dei Suoi poveri tutti i suoi “talenti”. Fu proprio Paolo VI, durante un’udienza, a dare a Candia i criteri giusti; «consigli – scriverà l’imprenditore in una lettera – che ritrovai poi sviluppati più ampiamente nella Populorum Progressio»: la struttura doveva essere «brasiliana», evitando ogni sorta di paternalismo, «cristiana» e «missionaria», ossia, non doveva mandare via nessuno. E così fu: entrato in funzione nel 1969, l’ospedale San Camillo e San Luigi sulle rive del Rio accoglieva tutti: per coloro che non disponevano di nulla (in media il cinquanta per cento dei ricoverati) avrebbe pagato il «presidente onorario», ovvero Marcello.
La gestione dell’ospedale, affidata poi interamente ai Camilliani nel 1975, si rivelò spesso faticosa. Guardato con sospetto dal governo locale e persino oggetto delle diffidenze dei compagni di missione, Marcello soffrì moltissimo (ebbe anche numerosi infarti), ma senza perdere la fiducia in Colui che lì l’aveva voluto: «Qui – scriveva nel 1972 ad un’amica milanese – il Signore ci aiuta sempre in maniera meravigliosa e sempre inaspettata, ma forse per questo e forse per farmi capire che sono di “dura cervice”, siamo stati provati e spesso sommersi di nuove difficoltà. E per sopravvivere non ci resta che la Fede semplice e salda, direi come fanno i nostri bambini della pediatria, quando piangono rumorosamente si aggrappano ed abbracciano le infermiere, le suore ed il medico quasi per non perdere l’istinto di vivere. Questa scena la vedo tante volte al giorno e quasi mi è di insegnamento, come al di là di ogni difficoltà, amarezza e fallimento umano, per colpa nostra o degli altri poco importa, c’è sempre e solo Gesù Cristo con la sua certezza di verità e di amore».
Qualche anno più tardi, Marcello avrebbe confidato ai suoi collaboratori la domanda che specialmente agli inizi della sua missione lo assillava: «Come farò quando saranno finiti i miei milioni?». Ma il miracolo gli fiorì ogni giorno sotto gli occhi: man mano che terminavano i suoi soldi, aumentavano quelli provenienti dall’Italia (persino dagli operai della sua ex fabbrica e dai senzatetto che aveva aiutato) e da tutto il mondo. Il bilancio dell’ospedale per i poveri, però, non smise di restare in passivo: «Il mio modo di pensare è cambiato – diceva agli amici –. Venendo dall’industria, sulle prime facevo previsioni, programmi, progetti […]. Pian piano mi sono accorto che quando si ha a che fare con Dio le cose cambiano. […] E così ho imparato che un ospedale per i poveri, per funzionare bene, deve essere sempre “in deficit”».
Nei numerosi viaggi compiuti per chiedere sostegno per le sue opere, però, più che parlare di denaro, ripeteva a tutti: «Pregate per me. Sono io che vi prego di pregare. I soldi, gli aiuti, le braccia, i ponti aerei, le decisioni di farmi da retroterra per sostenermi vengono dopo. Tutto viene dopo la preghiera. Io ho, per prima cosa, l’urgenza che voi accettiate di dire al Padre: “Signore, aiuta l’Ospedale sul fiume, la sua gente sofferente, quelli che le stanno attorno e si prodigano. Signore, tu solo puoi dare movimento ai progetti e agli scopi”».
Ed era proprio nella messa quotidiana e nell’ora di preghiera condotta ogni giorno nel silenzio del piccolo Carmelo di Macapá (che egli stesso costruì e volle dedicato a santa Teresina del Bambin Gesù) che Marcello traeva il sostentamento per reggere quella vita frenetica ai limiti dell’inverosimile: «Adesso me ne vado contento perché la preghiera mi ha rafforzato», diceva al termine delle orazioni, allargando le labbra in uno splendido sorriso.
 Che per Candia la preghiera fosse il cuore di tutto ciò che compiva in missione, lo testimonia anche il fatto che nell’altra sua grande opera, il lebbrosario di Marituba, prima di organizzarne la completa rimessa a nuovo, volle costruirvi al suo interno una Casa di preghiera, intitolata a Nostra Signora della Pace, dove portò suore e padri del Pime perché alleviassero non solo fisicamente ma anche spiritualmente le sofferenze degli hanseniani lì confinati. In quel luogo, da tutti ritenuto vera anticamera dell’inferno, e nell’amicizia di quegli uomini e donne sfigurati dal male degli “intoccabili”, Marcello trovò “il centuplo” promesso da Gesù. Specialmente nello sguardo dell’amico Adalucio, in quegli occhi scuri e lucidi come gocce di caffè che brillavano pieni di fede nel Signore, nel bel mezzo di un volto crudelmente ridisegnato dalla lebbra. Era di lui che Marcello si stava prendendo cura in quel giorno del 1980 in cui Giovanni Paolo II si recò in visita a Marituba; in quell’occasione Wojtyla si stupì di non trovare Candia sul palco con le autorità, ma nascosto tra i lebbrosi, intento a dar sollievo con un ventaglio all’amico più caro.
Che per Candia la preghiera fosse il cuore di tutto ciò che compiva in missione, lo testimonia anche il fatto che nell’altra sua grande opera, il lebbrosario di Marituba, prima di organizzarne la completa rimessa a nuovo, volle costruirvi al suo interno una Casa di preghiera, intitolata a Nostra Signora della Pace, dove portò suore e padri del Pime perché alleviassero non solo fisicamente ma anche spiritualmente le sofferenze degli hanseniani lì confinati. In quel luogo, da tutti ritenuto vera anticamera dell’inferno, e nell’amicizia di quegli uomini e donne sfigurati dal male degli “intoccabili”, Marcello trovò “il centuplo” promesso da Gesù. Specialmente nello sguardo dell’amico Adalucio, in quegli occhi scuri e lucidi come gocce di caffè che brillavano pieni di fede nel Signore, nel bel mezzo di un volto crudelmente ridisegnato dalla lebbra. Era di lui che Marcello si stava prendendo cura in quel giorno del 1980 in cui Giovanni Paolo II si recò in visita a Marituba; in quell’occasione Wojtyla si stupì di non trovare Candia sul palco con le autorità, ma nascosto tra i lebbrosi, intento a dar sollievo con un ventaglio all’amico più caro.
«Desideravo morire di una malattia pulita e invece dovrò morire sporco e pieno di piaghe. Per fortuna il Signore ci nasconde sempre il peggio». Era il 1983 quando, con queste parole, Marcello confidò in gran segreto alle Carmelitane del cancro alla pelle che lo affliggeva e che lo avrebbe consumato nel giro di pochi mesi. Intanto, all’ospedale, nella cerchia dei suoi collaboratori, erano iniziate le divisioni e qualcuno lo accusò perfino di aver rubato: «Sono ai piedi del Calvario – disse ancora alle suore amiche –. Mi sono preparato a salirlo. Pregate il Signore che mi aiuti». Un Calvario che sta tutto in un’immagine, ovvero quella che vede Candia, ormai sfinito nel corpo e provato nello spirito, salire a fatica e per l’ultima volta la scaletta dell’aereo che dall’amata terra di missione lo avrebbe ricondotto definitivamente nella sua Milano. A salutare per l’ultima volta «l’uomo più buono del Brasile» (così lo aveva definito la rivista Manchete) c’erano soltanto un missionario e un gruppetto di ragazzi handicappati. Sarebbe morto venti giorni dopo quel viaggio, il 31 agosto 1983, con il pensiero ancora rivolto ai poveri che aveva sempre amato e con il cuore contento: «Ho lavorato, ho pregato… ma adesso il Signore Gesù mi dà la cosa più alta, mi dà la sofferenza… donandomi la possibilità di abbandonarmi a Lui con tutta la mia gioia e il mio amore».
«Al di là delle opere e di quel poco di bene che possiamo fare, vale ben di più per i nostri fratelli che soffrono la testimonianza personale, cristiana e missionaria, per piccola che sia», scrisse in una delle sue ultime lettere. Quella testimonianza della quale, tra i tanti, fu spettatore il suo amico Gaetano Lazzati (fratello del più celebre Giuseppe, servo di Dio ed illustre esponente del cattolicesimo italiano).
«Conoscendo Marcello – dirà Gaetano, testimoniando nella causa di beatificazione di Candia – ebbi la sensazione di vedere il cammello che passa per la cruna di un ago».