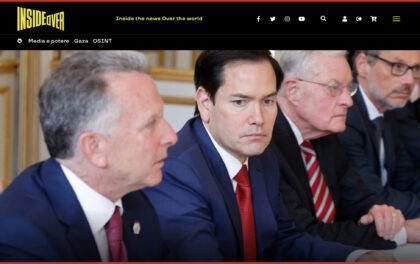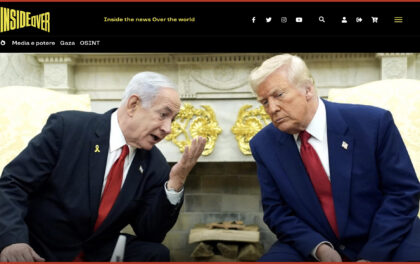Dall'asse Trump-Netanyahu a quello Harris-Barak?
 Tempo di lettura: 4 minuti
Tempo di lettura: 4 minuti
Kamala Harris è la nuova reginetta del mainstream Usa. La candidata democratica sta emergendo di forza nei dibattiti televisivi nei quali vari aspiranti si contendono la possibilità di sfidare Trump alle presidenziali del 2020. I sondaggi la danno in ascesa, tanto da minacciare il favorito Joe Biden.
Può apparire una notizia di secondo piano, ma tale non è, perché segnala il ritorno dell’ambito clintoniano nell’arena democratica dopo il momentum di Bernie Sanders e Barack Obama, i quali sembravano aver preso in mano il partito.
La Harris e il ritorno dei Clinton…
Finora, infatti, i candidati alle primarie si richiamavano al ciclone Sanders, che ha investito il partito nelle ultime primarie, facendo barcollare l’establishement liberal-clintoniano.
Dalla Ocasio Cortez a Tulsi Gabbard, da Beto O’Rourke a Elizabeth Warren, tutti i candidati democratici si richiamano alla radicalità di Sanders.
Per parte sua, Obama sembra a suo agio con tale ambito, che ha contribuito a far nascere, d’altronde l’establishement del suo partito l’ha sempre visto come un nemico, soprattutto per la sua ostinazione a perseguire l’accordo sul nucleare iraniano, del quale oggi si può comprendere l’importanza.
E la candidatura del suo ex vice-presidente, Biden, se da una parte sembra opporsi all’onda lunga di Sanders, dall’altra ne è il compimento, dato che Biden appare ancora come l’unico che può battere Trump, dato che attira i consensi decisivi del centro.
Così finora sembrava ovvio che a sfidare Trump fosse il binomio Biden-Sanders (o altro/a della sua scuola), con chances di vittoria, dato che gli avrebbe conteso i voti “populisti”.
In questo gioco politico si è inserita una variabile nuova, ovvero il clintonismo, con Kamala Harris, che pur emergendo dall’humus radicale, è diventata altro, come mostra la scelta del suo nuovo consigliere generale, Marc Elias, che ebbe già tale ruolo con la Clinton e, per inciso, è ancora al centro di accese controversie (fu lui a innescare il Russiagate contro Trump).
La Harris clintonizzata potrebbe dunque essere la prossima sfidante di Trump. Ma potrebbe essere utile alla causa liberal anche in caso di sconfitta alle primarie del partito, potendo rivestire, in caso di vittoria di un presidente democratico, incarichi da vice-presidente o Segretario di Stato. Ruoli che gli consegnerebbero influenza decisiva, come avvenuto con Hillary Clinton.
… e il ritorno di Barak in Israele
Per capire la svolta in tutta la sua portata va considerata anche un’altra variabile, la candidatura di Ehud Barak alle elezioni israeliane di settembre, in vista delle quali vuol fondare un nuovo partito. Abbiamo scritto in altra nota, alla quale rimandiamo (cliccare qui), l’importanza che riveste la sua candidatura.
Gli sviluppi della politica israeliana lo hanno rafforzato, grazie alla vittoria, nelle primarie del partito laburista, di Amir Peretz che, pur non essendo un suo uomo, sta cercando convergenze col partito di Barak, lasciando a lui la guida della coalizione (Timesofisrael).
Barak ha dunque la carte in regola per diventare premier israeliano oppure ministro della Difesa in un’eventuale governo Gantz o, anche se lo nega per ovvie ragioni elettorali, in un governo Netanyahu.
La sua nuova avventura sta scaldando cuori in Israele. Come dimostra l’articolo di Chemi Shalev su Haaretz, che immagina una sfida tra Netanyahu e Barak in Israele e la Harris e Trump negli Usa.
Il sogno è quello di vedere una parallela vittoria liberal in Israele e negli Stati Uniti, con la Harris alla Casa Bianca e Barak premier israeliano. Si ripeterebbe in tal modo quanto avvenne al tempo, quando la presidenza di Bill Clinton vedeva la parallela premiership di Barak in Israele.
L’asse Trump-Netanyahu verrebbe così sostituita dall’asse Harris-Barak. Cambiamento estetico, ma potrebbe non essere di sostanza, almeno per quanto riguarda il dossier che sta tenendo banco.
Barak tende ad avere un approccio muscolare verso l’Iran e le criticità connesse (Hezbollah, Siria). La Harris è invece favorevole all’accordo sul nucleare iraniano, addossando la responsabilità dello scontro con Teheran a Trump.
Né potrebbe dire diversamente in campagna elettorale: perderebbe consensi. Da vedere se, in caso di vittoria, manterrebbe tale posizione o se un’eventuale pressione di Barak, sovrapposta a quella neocon-clintoniana, avrebbe la meglio.
Ma il futuro è tutto da vedere. Resta che occorre registrare questo parallelo ritorno dell’onda liberal, che già governò il mondo in tempi andati dei quali è arduo serbare rimpianti.
Nella foto in evidenza. Luglio 2000: Yasser Arafat, Ehud Barak e Bill Clinton a Camp David, dove si sarebbe dovuto siglare un accordo per la nascita della Palestina. Nonostante l’enorme pressione, Arafat non accettò. Aveva fiutato la trappola: l’intesa doveva essere ratificata da un referendum da tenersi in Israele, che non sarebbe mai passato.
In realtà, essa serviva solo a portare alla vittoria il vice di Bill, Al Gore, alle presidenziali Usa previste di lì a poco. Il rifiuto di Arafat fu decisivo. Vinse George W. Bush, sul quale però si abbatté l’11 settembre… (su Bush e l’Iran vedi nota segnalata).